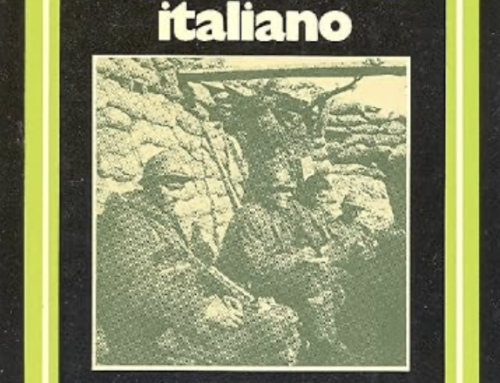La troppa fretta nella globalizzazione
Per scrivere questa riflessione attendevo che accadessero alcuni fatti:
a) la Daimler Benz tedesca richiama in servizio 300 pensionati, alcuni di essi hanno oltre 70 anni. La missione è semplice: far funzionare l’interfaccia tra i sistemi informatici e la catena di produzione in Asia;
b) molte imprese tedesche e non, quindi italiane e francesi, sono disorientate dal crollo del mercato russo, considerato uno dei più promettenti;
c) diverse aziende italiane stanno rientrando dai paesi dove avevano precedentemente delocalizzato (Romania e Cina);
d) un imprenditore italiano, attivo nel settore automotive, chiude in Cina il suo stabilimento di 3mila dipendenti, per trasferirsi in Messico;
e) giunge notizia di una joint venture in India, ferma perché la controparte indiana pretende molto di più rispetto quanto inizialmente stabilito per contratto.
La lista potrebbe proseguire, ma è sufficiente. Quali sono le considerazioni che emergono da questi fatti?C’è un filo conduttore comune: la fretta.
Fretta di presentare bilanci in forte crescita per incassare bonus, anche a costo di spingersi su mercati esotici che oggi ci sono, ma per domani non v’è certezza. La Russia è ancora preda di una dittatura utilitaristica, come la Cina non ha saputo risolvere l’equazione politica e sviluppo. Il problema si replica per il Brasile, l’India e la Turchia (paesi privi di certezza del diritto) e Sud Africa (eternamente in bilico e rassegnazione). In paesi di questo tipo è certamente possibile un azzardo, ma non di più, finchè non sapranno trovare una stabilità politica. Certamente pensare di sviluppare un’azienda sui mercati esotici è un rischio. La medesima superficialità coglie sia le imprese sia lo Stato italiano, quando proclamano l’ingresso trionfale di giovani congedando i maturi. Che i ragazzi debbano urgentemente entrare nel ciclo produttivo è strategico affinchè escano dalle famiglie, si sposino e facciano figli in età giovane per poterli educare adeguatamente.
Quindi il lavoro è una condizione di civiltà. Però i ragazzi vanno inseriti in un percorso formativo che si chiama carriera. Questo vuol dire, indicativamente, che devono studiare possibilmente fino ai 20-26 anni, quindi essere seguiti al lavoro per i successivi 15-20 e verso i 46-48 anni iniziare a dire la loro per giungere alla dirigenza sui 50. Oggi questo non accade. Sorrido quando leggo gli incarichi di molti attuali manager che intorno ai 35 anni sono già responsabili di marketing, del personale, amministrativi, della qualità, per salire poco dopo i 40 trovando direttori di produzione, commerciali etc.
Sorrido perché si tratta mediamente di personale a cultura incompleta in grado di produrre importanti guasti nelle aziende. E’ importante sottolineare che non basta l’età per la responsabilità, non serve avere solo 50 anni per “poter decidere”; necessita l’esperienza, ovvero il numero di volte che ci si è trovati con le pezze al sedere cercando soluzioni per cadere nuovamente e inesorabilmente rialzarsi.
Tradire questi concetti significa sicuramente essere alla moda, ma consente alla superficialità di governare un mondo più complesso. La stessa crisi subprime è frutto di ragazzini posti in condizione di comando. Concludendo: come se ne esce? Abbiamo spinto i maturi a correre verso la pensione e i giovani a livelli di responsabilità eccessivi per le esperienze maturate. Qualcosa non funziona. Per caso ce ne siamo accorti?